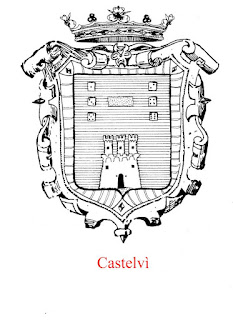a cura di Giuseppe
Ruiu
Il
poeta e la ragazza
Tratto da: R.
Manconi,“Vecchia Florinas”, Tipografia Stella Alpina, Novara, 1960, pp 111-116.
E adesso rievochiamo
qui una storia che da sola basterà a illustrarci certi aspetti del
costume e del carattere della nostra vecchia gente.
Giovanni Dore,
nativo di Cargeghe, aveva trasportato da giovane i suoi penati in
Florinas, menandovi per moglie una delle più belle e virtuose
ragazze, Giovanna Maria Fois, in tutto degna d'elogio che i romani
facevano alle loro migliori donne: domi mansit, lanam fecit.
Infatti il fuso e la
rocca furono i suoi compagni inseparabili fino alla tarda età, fatta
di giorni pieni di ricordi e di silenzi.
Agricoltore e
soprattutto mugnaio, Giovanni Dore aveva qualcosa di suo al sole e
conduceva due mulini ad acqua: uno in Briai (regione di Ossi - ndc) e
l'altro in s'Iscia (regione di Cargeghe - ndc).
I vecchi mulini di
Florinas e degli altri nostri paesi! Esercitavano un ruolo
fondamentale nell'economia locale e costituivano una nota di colore
nel quadro della vita paesana. A essi portavano il grano asinelli che
sparivano sotto il carico dei sacchi o cavalle che poi rimanevano in
attesa, scalciando per difendersi da mosche e da tafani.
L'acqua gorgogliava
nelle gore e scosciava sulle pale delle ruote, e dopo il polverone e
l'arsura del cammino sembrava più fresca, più preziosa proprio come
un magnifico dono di Dio. Il gemere delle mole e lo stridere delle
tramogge si univa al cicaleccio delle donne e alle strida dei
piccoli, interpuntati ogni tanto dal suono del campanello che
annunciava la fine di una macinata.
I molini
costituivano un centro di raccolta e di smistamento di notizie, e
perciò fungevano, per così dire, da agenzie locali d'informazione.
Infatti costituivano il luogo ideale dove ogni comare che aveva da
dire la sua circa fatti che la riguardavano da presso o da lontano
poteva improvvisare qualcosa di simile alle moderne conferenze stampa
innanzi alle compaesane pronte a fungere nel paese da gazzette
parlanti.
Poi, con l'arrivo
dell'energia elettrica, addio vecchi mulini ad acqua!
Addio ruote verdi di
muschio! E addio quadretti di vita paesana sotto il pulviscolo bianco
che si levava dalle macine a incipriare ogni cosa.
Adesso qualcuno di
quei mulini, solitario e diroccato, , dalle finestre senza impannate
sembra guardare con desolata fissità al passato.
Ma torniamo a
Giovanni Dore. Il suo matrimonio con Giovanni Maria Fois era stato
allietato da cinque figlie: Lucia, Maria Domenica, Giovanna Maria,
Maria Simona, e Franceschina, che gli crescevano in casa come
virgulti intorno alla quercia, per usare una similitudine biblica, e
di cui si sarebbe potuto dire che erano cinque in una, tale era in
esse la fusione dei cuori e delle menti. Dacché mondo è mondo,
cinque figlie hanno sempre costituito un problema, e spesso un
grattacapo, per qualsiasi padre; ma questo non era il caso di
Giovanni Dore, che tra l'altro, in fatto di pedagogia, doveva avere
poche idee, ma molto chiare.
Sua figlia Maria
Domenica era appunto giunta all'età in cui allora una bella ragazza
incominciava a dar da fare ai giovanotti con le serenate sotto il
balcone, quando in Florinas comparì per ragioni di servizio Giuseppe
Mereu, un giovane destinato ad accrescere il patrimonio isolano della
poesia dialettale.
Giuseppe Mereu era
nato in Tonara nel 1872, vi aveva frequentato le scuole elementari
e, rimasto orfano e privo di mezzi, si era arruolato nell'Arma dei
carabinieri, seguendo l'esempio di tanti altri giovani sardi che per
sottrarsi alla vita dei campi non avevano (e non hanno tutt'oggi)
altra scelta se non quella di mangiare «su
pane de su Re». Così
egli era venuto a capitare in servizio alla stazione dei carabinieri
in Codrongianos (che sovrintendeva oltre al territorio di
Codrongianos anche quelli di Florinas e Cargeghe - ndc). Come poeta
dialettale egli era destinato a un bel successo e le sue poesie
vengono stampate e diffuse tuttora anche a opera di venditori
ambulanti perfino nelle fiere e mercati dell'isola.
All'allievo
delle muse sarde sotto la lucerna del carabiniere non fu molto
difficile attirare l'attenzione della ragazza e farle capire che il
Cupido delle sue poesie aveva per lui dato fondo a tutti i dardi
della faretra.
Giuseppe
Mereu era tutt'altro che male come uomo, e come in tutti i poeti
degni di rispetto, anche in lui traspariva quel non so ché di
malinconico, quella spiritualità interiore che è il segno e il
suggello di un dono negato agli altri, inoltre era un carabiniere; e
qui occorre spiegarsi.
Erano
quelli i tempi in cui quando una pattuglia di carabinieri, nelle sue
perlustrazioni o nei giri di ronda, andava a bussare a un uscio, alla
domanda fatta dall'interno: «Chi
est?» si rispondeva:
«Su Re!».
Al che si replicava: «Bene
'ennidu su Re!». Ma
nella psicologia dei nostri vecchi non tutto correva liscio riguardo
all'Arma. Essa rappresentava il Re, al quale andava l'indefettibile
ossequio dei sudditi, ma rappresentava anche la legge: una legge che
spesso, al vaglio degli interessi personali, assumeva l'evidente
configurazione dell'ingiustizia.
Quindi
ossequio al Re, ma alla larga dai rappresentanti della Legge!
Questo
per gli uomini. Per le donne invece era un'altra faccenda, dato che
nel passato esse avevano sempre un debole per tutte le uniformi,
procedendo in parallelo la loro scala sociale e l'ordine della
gerarchia militare. Allora un carabiniere a cavallo, con tanto di
sciabola e di pennacchio e di cordelline, si portava via i cuori di
tutte le ragazze di un paese.
Bell'uomo,
e poeta in uniforme, Giuseppe Mereu aveva quindi numeri più che
sufficienti per far breccia nel cuore della ragazza. Incominciò così
tra lui e lei una «corrispondenza
d'amorosi sensi»
che, dati i costumi del tempo, non andava al di là delle occhiate
furtive nell'ombra della chiesa o dal balcone. Quando poi, grazie
all'assenza di occhi indiscreti, ci scappava anche qualche sorriso o
qualche rapido cenno, allora era giornata di festa, di quelle da far
scoppiare il cuore dalla gioia.
I
due innamorati non avevano perplessità circa i propri sentimenti e
le loro volontà; ma sentivano di navigare in un mare di dubbi quando
pensavano rispettivamente al proprio padre e al futuro suocero. Come
l'avrebbe presa egli? E se avesse detto recisamente: no? Che guai
allora! In casa ogni suo parere era un ordine tacito, e in famiglia
la sua volontà era legge. I guai purtroppo non tardarono, dato che
tosse e amore non possono nascondersi a lungo, e incominciarono col
fatto che Giovanni Dore avesse istintivamente in antipatia i
rappresentanti della Benemerita e che un genero carabiniere, anche se
poeta, non rientrava affatto nei suoi ideali. Non dimentichiamo che,
in quel tempo, i carabinieri condividevano con i marinai la fama di
essere specialisti nell'arte di corteggiare le ragazze, collezionando
fidanzate ovunque. Forse dovettero influire anche le sue
considerazioni sull'autorità paterna, sull'obbedienza e la
confidenza filiale, eccetera, a farlo andare sulle furie appena,
messo sull'avviso, ebbe dalla figlia la sincera confessione
dell'avvio preso dalla faccenda.
Nella
casa di Giovanni Dore scoppiò una tempesta che investì tutte le
donne, le quali attesero in silenzio che tuoni e fulmini
dileguassero.
Come
Dio volle, la tempesta si acquietò, ma in un silenzio che non
presagiva niente di buono. Infatti, di lì a poco, la colpevole fu
chiamata a sentire la punizione che le aveva inflitta: la
segregazione a tempo indeterminato nel mulino di Briai, sotto la
sorveglianza di una zia.
Seduta
stante il padre montò a cavallo e s'avviò verso Briai, seguito
dalla figlia che camminava a piedi, scalza per maggior punizione. I
lettori non avranno difficoltà a immaginare quella scena e che cosa
passasse quel giorno nel cuore di quella figlia così sottomessa.
Il
poeta carabiniere precipitò in una autentica disperazione, e per la
sua bella segregata chiese soccorso a Dio e per se a tutte le Muse,
questa volta chiamate da lui a piangere sinceramente sulle sventure
d'amore e assai più del consueto. Ma per lui era impossibile vivere
senza nemmeno vedere i luoghi dove la sua bella era stata confinata,
seguendo un costume che ricordava quello descritto in certe novelle
medioevali, in cui inflessibili genitori chiudevano in castelli o
torri le figlie di cui volevano impedire i non graditi amori. Per
ciò, quando era libero dal servizio, egli usciva dalla caserma e poi
via, per costoni e scorciatoie impossibili, fino a una cima da dove
si vedeva il mulino fatale. Là, su quella cima, l'innamorato sostava
quasi in contemplazione, in compagnia delle muse, e pur nella sua
pena giungeva quasi a sentirsi felice. Di capitare ogni tanto al
mulino, magari col plausibile pretesto del servizio e in compagnia di
un commilitone, non c'era neppure da pensarlo per non aggravare di
più la situazione.
Però
quelle passeggiate diurne non bastavano a soddisfare il cuore del
giovane, così ch'egli prese a farne anche delle notturne, sempre per
raggiungere quella tal cima da dove magari veder trasparire dal
mulino qualche luce che gli desse come una visione dell'amata. Quelle
passeggiate, considerando il loro percorso, costituivano già una
bella impresa di giorno; immaginiamoci poi di notte, se per giunta
non vi era chiaro di luna. E non si dimentichi il rischio di una
punizione esemplare da parte dei superiori per l'infrazione fatta ai
regolamenti.
Purtroppo
il destino aveva deciso di servirsi dell'amore per giungere ad
abbreviare gli anni di Giuseppe Mereu. In una notte piena
dell'oscurità più densa, egli, nel guadare un torrente alla volta
di quella cima, accaldato com'era scivolò e cadde nell'acqua
infradiciandosi fino al midollo. Quel bagno involontario fu per lui
la causa di una ostinata infreddatura dalla quale poi, per
trascuratezza del giovane e per imperizia dei medici, doveva
originarsi una tisi inguaribile.
Intanto
il parentado della ragazza, coalizzatosi in difesa dei due
innamorati, riuscì a spuntarla e a far recedere Giovanni Dore dalle
sue decisioni. Egli chiamò allora un suo servo pastore e gli ordinò
di recarsi a Briai per dire alla figlia di tornare a casa, essendo
stata perdonata. Il resto si sarebbe deciso in seguito. Il servo recò
l'imbasciata ma con suo stupore si sentì domandare: «Che segno
certo ho io che veramente è volontà di mio padre che io faccia
ritorno a casa?»
Il
servo ritornò indietro, forse facendo in cuor suo chissà che
commenti, e riferì.
«Bene!»
- disse allora Giovanni Dore, togliendosi di tasca il grande orologio
d'argento di cui andava particolarmente fiero – Prendi questo, e dì
a mia figlia che venga a riportarmelo». E così fu fatto.
Se
la prima parte di questa storia è molto romantica, la seconda invece
è molto malinconica.
Tutti
consenzienti, i due giovani si scambiarono in forma non ufficiale la
promessa di matrimonio; ma la tisi aveva preso a fare rapidi
progressi nel giovane, che passò in cura nell'infermeria presidiaria
di Sassari e nell'ospedale militare di Cagliari e infine venne
dimesso dall'Arma.
Con
ciò finirono anche i sogni e le speranze dei due innamorati. Lui
sciolse lei da ogni impegno e si ritirò nella nativa Tonara ad
attendervi la fine. Della corrispondenza intercorsa tra i due si
conservano ancora fino a qualche anno fa alcune lettere e diverse
liriche amorose, scritte in italiano o in dialetto, e rimaste
inedite.
Lui
si avviò al compimento del suo destino col travaglio spirituale che
traspare dalla raccolta delle sue liriche, pubblicate nel 1897 a cura
di un caro amico, e morì nel 1901. Lei, chiusa nel rimpianto, dopo
aver respinto per dieci anni ogni altra richiesta di matrimonio,
aderendo alle pressioni dei parenti passò alla fine a nozze, ma era
stabilito che anche per lei la vita doveva essere breve. Morì
infatti il giovedì santo del 1918 in Florinas, dove dalla città in
cui era andata ad abitare era rientrata per venire assistita nel male
inesorabile che l'aveva colpita, e volle essere sepolta vestita del
costume con cui era andata sposa all'altare. Forse, il giorno dopo le
sue esequie, le campane di Florinas e di Tonara presero a squillare
insieme nell'alleluia pasquale.
Biografia di Peppino Mereu da: «Ichnussa. Progetto di pubblicazione e
divulgazione libera della grande poesia in lingua sarda».
La medesima vicenda descritta nel presente lavoro, tratta sempre da:
«Ichnussa. Progetto di pubblicazione e divulgazione libera della
grande poesia in lingua sarda».
La
bella di Florinas fu l’unica donna amata dal poeta
A
Tonara, fino a domani, la tre giorni dedicata al poeta Peppino Mereu:
Domenica, poesia per l’amore perduto.
Si
pro casu unu paccu sigilladu agatades, domando, pro favore, non siat
su sigillu profanadu./Cuntenet un’istoria de dolore: sunu litteras
d’un’isfortunada, dulche poema d’unu veru amore./(…)/De
cuss’amore nde tenzo sa morte, a’ s’ora de sa vida sa pius
bella. Ah! Decretu fatale e dura sorte!/ Tue, in battor muros de una
cella, ses pianghende e preghende in segretu, pover’isconsolada
verginella!
Florinas.
Maria Domenica Dore aveva trentatré anni e nessuna luce negli occhi
il giorno in cui si rassegnò a sposare un uomo che non amava. Per
due lustri, dopo la fine del suo grande amore, aveva vissuto reclusa
in casa, come una monaca: mai più una festa, mai più un’uscita in
campagna con le sorelle, mai neanche l’accenno di un sorriso.
Leggeva e rileggeva le lettere che conservava in un cassetto,
accarezzava i fiori di campo essiccati che lui - in quei pochi mesi
di gioia che Dio concesse al loro sentimento - le aveva spedito in
mezzo ai foglietti delle poesie, pregava senza più speranza. Un
giorno d’inverno del 1909 sposò Antonio Michele Manconi, brav’uomo
del paese con uno stipendio di guardia carceraria e una vita
sacrificata da una città all’altra. Solo il primo figlio, Lorenzo,
nacque a Florinas, gli altri due - Giovannico e Mariuccia - a
Cagliari e a Oristano. Ebbe un poco di gioia soltanto dai suoi
bambini, e quando morì - a quarantadue anni, il Giovedì santo del
1918 - le zie consolarono gli orfani, i compaesani fecero le
condoglianze al vedovo e tutti dissero che Maria Domenica Dore, in
fondo, era già morta il giorno in cui lei e Peppino Mereu avevano
rotto la promessa di matrimonio.
«Era
un bel giovane. Alto, slanciato, portava con eleganza la divisa dei
carabinieri a cavallo. Fin da bambina, qui in casa, ho sempre sentito
parlare di Peppino Mereu e di zia Domenica. Per anni, in famiglia,
abbiamo conservato le lettere che lui le scriveva. Le custodiva zia
Gavina Luigia Carboni, la sorella di nonno: gliele aveva consegnate
zia Domenica prima di sposarsi. “Tienile tu, sono la cosa più cara
e preziosa che ho”, disse. Per tanto tempo vennero tenute come
reliquie, ma poi purtroppo sono andate perse durante un trasloco».
Domenica Carboni ha 86 anni, lo stesso nome della sfortunata zia e
gli stessi tratti dolci del viso. Nel soggiorno della casa di
Florinas le foto di questa grande famiglia di donne sono incorniciate
alle pareti e sui ripiani della credenza. C’è zia Gavina Luigia,
la sorella del nonno paterno, che cercò sempre di aiutare i due
innamorati di questa storia; c’è Maria Domenica, bella come
un’attrice del cinema muto; ci sono le sue quattro sorelle (lei era
la secondogenita) Lucia, Giovanna Maria, Maria Simona («che era mia
madre») e Franceschina. «Questa è una parte importante della
storia della famiglia, ma le lettere, purtroppo, quelle non ci sono
più». Già, le lettere. Nell’epica dell’amore sfortunato tra
Peppino Mereu e la figlia del mugnaio Giovanni Dore, restano un
mistero mai svelato. Perdute chissà come quelle scritte dal poeta;
mai ritrovate - invece - quelle che gli spedì l’innamorata, le
stesse che Mereu, poco prima di morire, sistemò dentro una scatola
assieme al ritratto della mamma e alla fotografia di Maria Domenica,
l’unica donna che abbia mai amato.
Giuseppe
Mereu aveva appena vent’anni quando, nel 1892, arrivò a
Codrongianos per prendere servizio nella caserma dell’Arma. Si era
arruolato nei Regi Carabinieri per sfuggire a un destino segnato come
servo pastore o massaio appresso al giogo dei buoi, e intanto
scriveva le sue liriche sognando di poterle pubblicare. Un giorno,
mentre passava a Florinas assieme a un commilitone, incrociò lo
sguardo di Maria Domenica Dore e da allora, tra lui e la figlia del
ricco mugnaio del paese, nacque un amore fatto di cenni del capo,
occhiate furtive, sorrisi discreti. «Zia Fois, la sorella della
mamma, sapeva di questo sentimento e cercava di aiutare la nipote. I
guai però - racconta Domenica Carboni - cominciarono quando il
padre, Giovanni Dore, scoprì tutto. Lui, come tanti a quel tempo,
era convinto che i carabinieri fossero uguali ai marinai, pieni di
fidanzate in ogni paese. “Senti”, gli diceva zia Fois, “perché
non chiedi al maresciallo oppure a qualcuno di Tonara di che famiglia
è questo ragazzo?”, ma lui non voleva sentire e, per tutta
risposta, decise di allontanare la figlia e rinchiuderla nel mulino
di Briai , lontano dal paese, sorvegliata a vista da zia Fois».
Peppino Mereu, disperato, cominciò a fare avanti e indietro - a
piedi, qualche volta pure di notte - per poter vedere la sua
innamorata anche solo un minuto. «Alle volte zia Fois permetteva
anche che si scambiassero qualche parola, ma niente di più: quelli
erano tempi in cui una ragazza doveva conservarsi casta e pura». Una
notte, mentre andava al molino, scivolò nel fiume. «È da allora,
dicevano le mie zie, che Peppino Mereu cominciò a stare male».
Intanto Giovanni Dore venne a sapere, da alcuni venditori di castagne
di Tonara, che quella del giovane carabiniere era una famiglia
rispettabile e onorata, «sicché si decise a dare il suo consenso e
a far rientrare la figlia a casa. Purtroppo, però, i due innamorati
non hanno visto un’ora buona. Peppino Mereu, dopo quella brutta
infreddatura nel fiume, si ammalò gravemente di tisi, venne
ricoverato nell’ospedale militare di Cagliari e subito congedato
dall’Arma». Fu così che, proprio perché malato e senza più la
possibilità di mantenere una moglie, decise di sciogliere la
promessa di matrimonio. Tornò a Tonara, dove morì nel 1901, mentre
Maria Domenica Dore - confinata nella sua casa di Florinas - per anni
visse nel ricordo di quell’amore sfortunato. «Per più di dieci
anni fece una vita di clausura. “Perché non esci?”, le chiedeva
il babbo, e lei rispondeva: “E dove vado, a vedere Peppino?”».
Alla fine dovette cedere alle pressioni del padre, «che la voleva
vedere sistemata: a quel tempo una donna doveva avere un marito», e
sposò Antonio Michele Manconi. Fu una moglie devota, e per i suoi
tre bambini una mamma dolcissima. Quando, tanti anni dopo, il
primogenito Lorenzo scrisse un libro dedicato al paese, Vecchia
Florinas , dedicò un intero capitolo all’amore tra sua madre e il
poeta di Tonara. «Mamma - confidò Lorenzo Manconi - mi raccontava
sempre di quel sentimento che portava nel cuore. Ero un bambino, ma
lei voleva che sapessi. Mi diceva: “Ascolta, figlio mio, ascolta.
Questa è stata tutta la mia vita”». PIERA
SERUSI
Descrizione del mulino di Briai da: «Mulini di Sardegna a cura di
Giuseppe Piras».